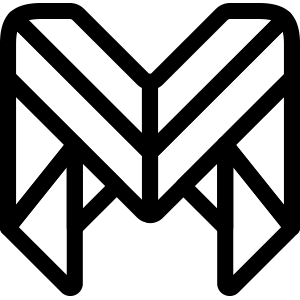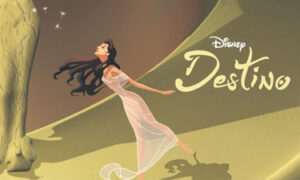Oggi ci concentriamo sull’episodio che, in prossimità del 25 aprile, Festa della Liberazione, ha riproposto il racconto degli eventi cruciali che segnarono la fine del regime fascista e l’alba della Repubblica Italiana.
La puntata si apre con un’introduzione che sottolinea l’importanza di rievocare annualmente la “fine rovinosa” dell’Italia fascista tra il 1943 e il 1945 e la contemporanea nascita di un’Italia nuova, erede dei principi di libertà e garanzie sanciti dalla Carta Costituzionale. Viene ricordato come questa Costituzione sia stata “guadagnata col sangue” grazie al sacrificio di 47.000 giovani durante la guerra di Liberazione e la Resistenza.
Ospite d’eccezione, lo scrittore Antonio Scurati, autore della monumentale opera dedicata a Mussolini. Insieme al conduttore, Scurati concorda sul fatto che quest’anno il 25 aprile assuma un significato particolare, anche in concomitanza con l’uscita dell’ultimo volume della sua tetralogia, intitolato non a caso “La fine e il principio”, che racchiude gli eventi tra la fine di luglio del 1943 e il 25 aprile del 1945: la fine di Mussolini e del fascismo, e l’inizio della nuova Italia. Scurati auspica che questo anniversario sia l’ultima occasione per chi proviene “dal lato sbagliato della storia” di riconoscere i valori fondanti della Repubblica nella Resistenza, sottolineando il valore della lotta per la libertà, la dignità umana e la pace.
Si affronta anche la questione del peso effettivo della Resistenza, con Scurati che ribadisce come, grazie al sacrificio dei partigiani, l’Italia abbia potuto sedere al tavolo delle nazioni che volevano la pace nel dopoguerra e scrivere la propria Costituzione, anziché farsela imporre da potenze straniere.
Il racconto si snoda attraverso le fasi cruciali della caduta di Mussolini, a partire dal suo sbarco a Ponza il 28 luglio 1943, descritto come un uomo smarrito e privo di tutto, un “cadavere vivente” come lui stesso si definì in una lettera alla sorella Edvige. Viene evidenziato il contrasto tra il suo precedente potere e la sua improvvisa prigionia nello stesso luogo dove aveva recluso i suoi oppositori, tra cui Pietro Nenni.
Un punto centrale della discussione riguarda il periodo della Repubblica Sociale Italiana, definita da Scurati uno “stato fantoccio” che mascherava e avallava una feroce occupazione nazista. Viene sottolineata la grave colpa di Mussolini nell’aver dato il proprio avallo a questa occupazione, scatenando di fatto la guerra civile. Scurati riflette anche sul presunto “pregiudizio antico” degli italiani di cambiare fronte durante i conflitti, citando le parole sprezzanti di Goebbels che definì gli italiani “un popolo di zingari”. Scurati stigmatizza il disprezzo contenuto in queste parole e lo paragona a simili atteggiamenti riscontrati nella politica mondiale contemporanea. Viene inoltre evidenziato il tradimento compiuto dai nazisti con la loro guerra di sterminio a Oriente e da Mussolini nel mantenere l’alleanza, mandando gli italiani a morire al fianco dei loro oppressori.
Un momento toccante della puntata è la lettura di un estratto che narra la prigionia di Liliana Segre e suo padre Alberto nel carcere di San Vittore e la loro successiva partenza verso la morte dal binario 21 della stazione di Milano.
Si affronta poi il tema dell’inizio della guerra civile, individuato da Scurati nell’ottobre 1943 a Milano con le azioni dei GAP (Gruppi di Azione Patriottica) e le conseguenti rappresaglie. Milano viene descritta come una città “infernale” che visse 600 giorni di terrore, tra la spietata repressione fascista e nazista con torture e fucilazioni, e i bombardamenti alleati. Scurati sottolinea la ferocia cieca esercitata dai fascisti e dai nazisti contro i loro concittadini.
Viene citata una lettera di Daciano (Edda) Ciano, figlia di Mussolini, che già nel dicembre 1943 riconosceva la futilità della guerra e l’inevitabile sconfitta, in contrasto con l’ostinazione di Mussolini e degli altri gerarchi. Scurati esprime il suo rammarico per la mancanza di compassione di Mussolini verso il suo popolo sofferente, rilevando invece un suo “agghiacciante” sentimento di tenerezza per sé stesso.
La puntata ripercorre anche il tentativo di mediazione del cardinale Schuster nelle ultime ore del regime e la fuga di Mussolini da Milano e poi da Como, abbandonando i suoi stessi seguaci. Viene evidenziato come Mussolini non volesse cadere nelle mani dei partigiani, ma sperasse di essere giudicato dagli americani. Scurati sottolinea la tragedia che investì anche gli ultimi fascisti, dimenticati dal loro leader.
Una scelta narrativa di Scurati è quella di non raccontare direttamente la morte di Mussolini, preferendo concentrarsi sulla “pietà dell’arte e della letteratura” per i suoi ultimi momenti. Pur comprendendo le ragioni storiche e psicologiche dello “scempio” del cadavere in Piazzale Loreto, Scurati non lo condivide, vedendolo come un possibile “vizio d’origine” della Repubblica.
Vengono mostrate immagini di Piazzale Loreto e ricordati i due eventi tragici che lo hanno segnato: l’uccisione di quindici ostaggi nel 1944 per rappresaglia a un attentato e, un anno dopo, l’esposizione dei cadaveri di Mussolini e di altri gerarchi fascisti. Viene sottolineato come quest’ultimo atto fosse una macabra replica delle violenze fasciste.
Nella seconda parte della puntata interviene la professoressa Michela Ponzani, che presenta il suo libro “Donne che resistono”, dedicato alle vedove, madri e figlie delle vittime delle Fosse Ardeatine che si sono battute per la memoria e la giustizia. Viene sottolineato il ruolo fondamentale e spesso dimenticato delle donne nella Resistenza, non solo nelle azioni armate ma anche nella resistenza civile, come staffette, informatrici e nel garantire la sopravvivenza.
Si affronta il tema della persistente divisione sulla Guerra di Liberazione, con Ponzani che la attribuisce a una “narrazione nostalgica” postfascista che ha edulcorato la storia del regime e screditato la Resistenza. Vengono citati esempi di questa narrazione e la mancanza di memoria storica del paese, talvolta alimentata anche da dichiarazioni istituzionali.
La puntata si conclude con un omaggio ai giovani partigiani e partigiane che hanno combattuto per la libertà e l’onore dell’Italia. Vengono ricordate la liberazione di Genova come esempio di autonomia della Resistenza e le parole di Piero Calamandrei sull’importanza della Costituzione come testamento dei sacrifici compiuti. Viene infine sottolineato come la Costituzione italiana sia nata da un libero dibattito, a differenza di quelle scritte sotto sorveglianza straniera.